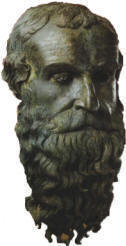"Atlantis.
Indagine
bibliografica dalle fonti di Platone fino agli scrittori moderni e le
ipotetiche ricostruzioni cartografiche"
"Atlantis.
Indagine
bibliografica dalle fonti di Platone fino agli scrittori moderni e le
ipotetiche ricostruzioni cartografiche"
a cura di
Ernesto Paleani..

LA
TRADIZIONE TESTUALE DEL TIMEO
Il Timeo è stato trasmesso,
con gli altri dialoghi di Platone, in un corpus organizzato
secondo l’ordinamento tetralogico (nove gruppi di quattro per
complessivi 36 dialoghi, alcuni dei quali giudicati non autentici
dalla critica moderna). Il Timeo occupa il 3°
posto (dopo la Repubblica) dell’VIII tetralogia.
L’origine del corpus che ci
è illustrato nella sua composizione da Diogene Laerzio (sec. III
d.C.) sembra risalire alla tradizione accademica, più precisamente
all’Accademia di mezzo (metà del sec. III
a.C.). Si discute se sia stata allestita una vera edizione
con la funzione di proteggere il lascito platonico dagli attacchi
strumentali delle altre scuole filosofiche. I papiri platonici di età
tolemaica del Lachete e del Fedone, pur nel loro stato
frammentario, hanno portato nuova luce sulla prima fase della
circolazione del testo platonico. I molto più numerosi papiri di età
romana e i testimoni della tradizione indiretta, da Cicerone (che
traduce il Timeo e lo cita più volte accanto ad altri
dialoghi) fino a Stobeo (che nella tarda antichità raccoglie in
un’antologia vari excerpta di poeti e prosatori) consentono
di confrontare utilmente il testo con quello dei codici medievali.
Nel sec. IV d.C. la fondazione della Biblioteca di Costantinopoli ad
opera di Costanzo II (357) segna una tappa importante nella storia
del testo in quanto promuove la confezione di nuovi esemplari nella
forma del codice, capace di ospitare un contenuto testuale ben più
ampio dei rotoli di papiro. Il corpus tetralogico di Platone
per la sua mole viene diviso in due tomi (tetralogie I-VII e VIII-IX).
L’attività esegetica a Platone,
iniziata già in età ellenistica, conosce un periodo di particolare
fioritura nella tarda antichità, nella scuola neoplatonica di Atene
(è conservato il commento al Timeo di Proclo) e alessandrina
(Olimpiodoro). I più antichi manoscritti di Platone risalgono al
sec. IX (l’età del primo Umanesimo bizantino in cui i testi degli
autori greci vengono copiati nella scrittura libraria ‘minuscola’):
il Parigino gr. 1807 che contiene il secondo tomo dell’opera
completa di Platone, quindi anche il Timeo, il Bodleiano
Clarkiano 39 contenente le prime sei tetralogie, il Vaticano gr. 1
(che è complementare al Bodleiano).
Vengono
poi in successione cronologica altri testimoni ‘primari’: il
Vaticano Palatino gr. 173 (sec. X), il Tubingense gr. Mb 4 e il
Vindobonense Phil. Gr. 7 (sec. XI), il Marciano gr. 185 (sec. XII).
Alcuni di questi codici, che daranno vita ad una ricca tradizione
successiva con una catena di copie, presentano il testo coronato da
scoli marginali, frutto dello spoglio e della selezione di varie
opere esegetiche precedenti (in particolare dei commenti
neoplatonici).
Platone continua ad essere trascritto
nel tempo in diversi ambienti culturali; un punto nodale della
tradizione bizantina è la cosiddetta rinascenza dei Paleologi (fine
sec. XIII, inizio sec. XIV) che fa seguito a un periodo di stasi
culturale: ora si cercano nuove fonti testuali, si mettono in
cantiere ‘edizioni’ degli autori antichi, utilizzando i
manoscritti conosciuti e spesso contaminandoli. Tra le memorie
testuali molto antiche felicemente recuperate c’è quella che poi
ha dato origine al Vindobonense Suppl.Gr. 39 che contiene una scelta
di dialoghi tra i quali il Timeo, con sensibili varianti
rispetto alle altre fonti. All’inizio del sec. XIV a
Costantinopoli vengono confezionati due grossi manoscritti, ognuno
con l’intero corpus platonico, arricchito da vari scritti
introduttivi alla lettura di Platone. Uno di questi manoscritti (il
Laurenziano 85,9), portato a Firenze al tempo del Concilio del 1438,
è stato riconosciuto come la principale fonte greca della
traduzione di Marsilio Ficino che fu pubblicata nel 1484 e fece
conoscere all’Occidente latino l’opera platonica ben prima che
il testo fosse stampato in greco (l’editio princeps aldina
è solo del 1513). L’Occidente aveva già conosciuto alcuni
dialoghi in versione latina: il Menone e il Fedone latini
(noti anche al Petrarca) erano stati tradotti nella Sicilia
normanna, nel sec. XII, da Enrico Aristippo; la conoscenza del Timeo
si deve invece nell’intero arco del MedioEvo alla traduzione
(fino a 53b) e al Commento di Calcidio (sec. IV) che ha avuto grande
fortuna fino al primo Umanesimo, all’età della ‘riscoperta’
di Platone.
Bibliografia
selettiva
G. Pasquali, Storia della
tradizione e critica del testo, Firenze 19522, pp.251-269
L. Canfora, Le collezioni
superstiti. I filosofi, in Lo spazio letterario della Grecia
antica, vol. II: La ricezione e l’attualizzazione del testo,
Roma Salerno Editrice, 1995, pp. 199-206
G.
Jonkers, The Manuscript Tradition of Plato’s Timaeus and
Critias, Dissert. Amsterdam
1989
J.
Irigoin, Deux traditions dissymétriqes: Platon et Aristote,
in Tradition et critique des textes grecs, Paris Les Belles
Lettres, 1997, pp. 149-190
Corpus dei papiri filosofici greci
e latini (CPF). Testi e lessico nei papiri di cultura greca e
latina, Parte I, vol. 1*** (Platonis fragmenta), Firenze
Olschki, 1999, pp. 33 ss.
G.M. Rispoli, Pseudepigrafi
platonici e filologia filosofica, in La Letteratura
pseudepigrafa nella cultura greca e romana, Atti di un Incontro
di studi Napoli, 15-17 Gennaio 1998, A.I.O.N. sezione
filologico-letteraria 22 (2000), pp. 453-511
Introduzione a Platonis Respublica,
recognovit brevique adnotatione critica instruxit S.R. Slings,
Oxonii 2003
a cura di Antonio Carlini

| Libri in esposizione |
Prima esposizione di libri del
"Fondo" in Palazzo Ubaldini con visione delle schede
delle pubblicazioni |
| Cdrom e DVD |
Cdrom e DVD home video |
| ricostruzioni cartografiche
estratte dai libri esposti |
ingrandimenti di carte geografiche che
ricostruiscono il sito di Atlantide |
|
|
PALAZZO UBALDINI |
|
Sede del Centro
internazionale di studi geocartografici storici laboratorio di
ricerca iscritto al MIUR dell'Editore Ernesto Paleani |