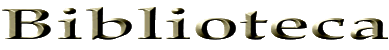2007 Cdrom a cura di Ernesto
Paleani della “Enciclopedia
multimediale degli Appennini” Cdrom. 3, La
Flaminia romana nel tratto tra il passo del Furlo
e Scheggia. Itinerario storico, geologico e
archeologico, in collaborazione con Roberto
Franchi, Simone Magi, Elvio Moretti (Università
degli studi di Urbino – Facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali).
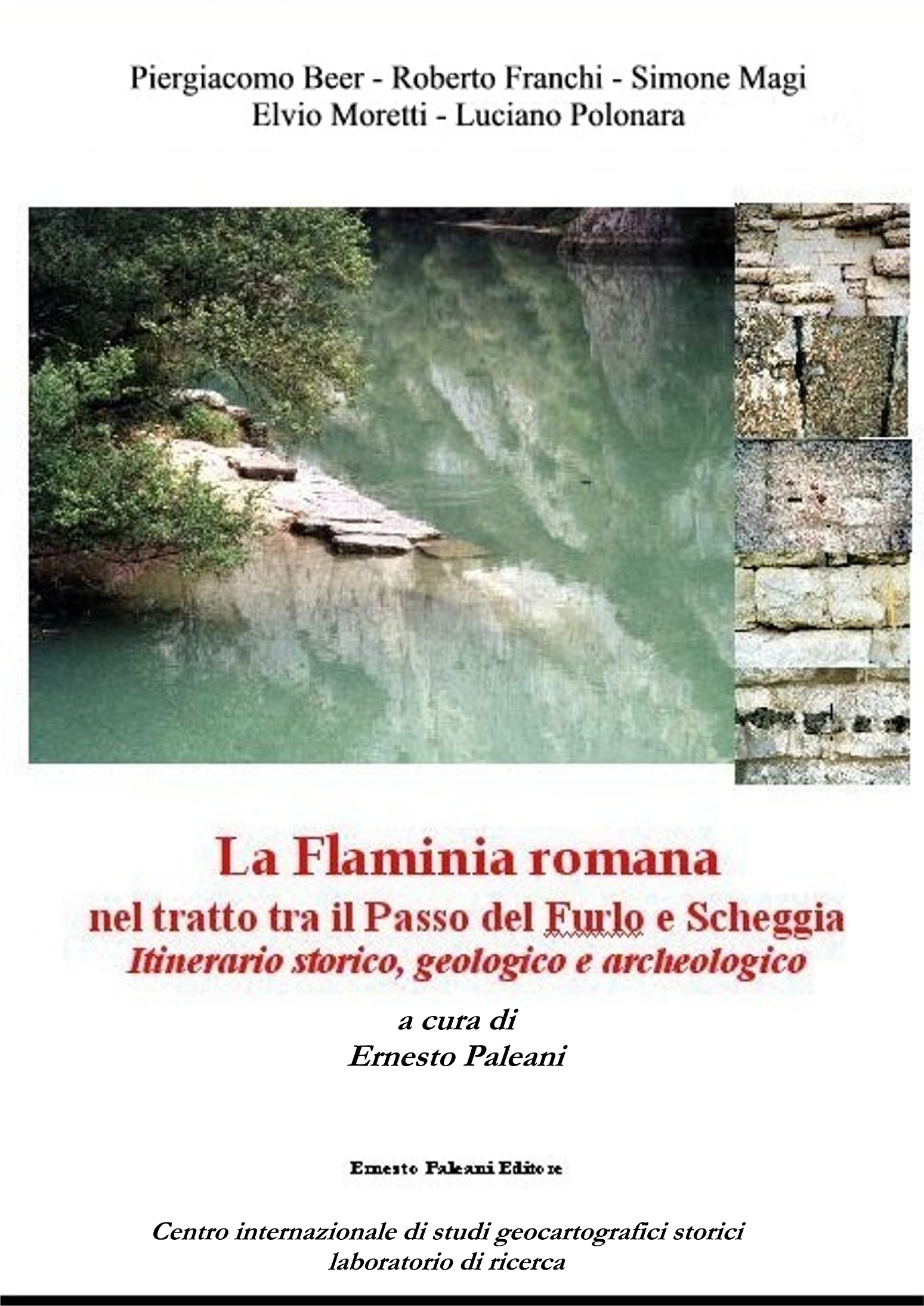
Questo lavoro di Simone Magi s’inserisce in una
collaborazione scientifica esistente tra la
sovrintendenza archeologica delle Marche e
l’Università di Urbino. Al progetto per la messa
in sicurezza e la conservazione del Ponte Tre
Archi in località Pontericcioli hanno inoltre
collaborato la Regione Marche, il Comune di
Cantiano e l’ordine dei geologi delle Marche. I
lavori sono iniziati nel 1999 e, in più fasi di
intervento, sono continuati negli anni
successivi e sono tutt’ora in corso. Attualmente
il ponte è in una situazione di sicurezza e sono
stati effettuati i restauri più importanti. La
campagna di scavo non è tutt’ora conclusa e
quindi proseguirà negli anni successivi. Sulla
base dei dati e delle ricerche geologiche,
geomorfologiche, analitiche e
storico-archeologiche su questo sito, si è
pensato di confrontare i dati e i risultati con
quelli di altri manufatti (ponti, viadotti, muri
di sostruzione) riferibili alla Flaminia romana
nel tratto tra il Passo del Furlo e Scheggia.
Tale confronto si ritiene utile al fine di
definire i tipi litologici e i materiali litoidi
generalmente utilizzati nelle costruzioni, le
loro caratteristiche geometriche e
composizionali-tessiturali per individuare le
formazioni di provenienza e quando possibile le
località di estrazione. I materiali utilizzati
appartengono comunque alla successione
Umbro-Marchigiana e sono riferibili
principalmente alla formazione della Corniola e
in alcuni casi, come al Ponte Tre Archi, ai
livelli arenitici della formazione Marnosa
Arenacea; sono state utilizzate anche delle
brecce cementate composte da elementi
eterometrici a spigoli vivi provenienti da varie
formazioni della successione Umbro-Marchigiana
(Corniola, Maiolica, e il gruppo delle Scaglie)
la cui provenienza è ancora in fase di studio;
sono poi presenti subordinati blocchi di
travertino; in questi siti non viene fatto un
uso del materiale cotto.
E’ stata fatta
inoltre una ricerca essenzialmente bibliografica
condotta
sia come conoscenza di base per
l’inizio del lavoro sia come integrazione
durante lo svolgimento dello stesso con la quale
si sono accumulate tutte le conoscenze sulle
modalità di costruzione delle varie strutture; e
in particolare è stato indagato il metodo
dell’Opus Quadratum che sicuramente è quello più
utilizzato almeno nelle opere di età Augustea.
Sono state svolte inoltre indagini di tipo
archeometrico consistenti essenzialmente in:
diffrattometrie ai raggi X, determinazione del
contenuto del carbonato di calcio, analisi
granulometriche e uno studio petrografico in
sezione sottile.
Inoltre questa tesi ha
previsto un rilevamento di terreno legato alla
presenza delle coperture detritiche recenti.
Questo tipo di indagini è importante e
necessario perché è stato notato che il percorso
in sui si snodava l’antico tracciato della
Flaminia romana nel tratto tra Pontericcioli e
Scheggia è molto spesso sepolto da un accumulo
detritico di spessore metrico. Il risultato
finale della tesi, oltre ad ampliare le
conoscenze sui vari siti archeologici presenti
lungo la Flaminia romana nel tratto tra il Passo
del Furlo e Scheggia, è stato anche quello di
tentare delle ipotesi su un differente tracciato
nel tratto tra Ponte Voragine e Scheggia.
Biblioteche lettura del testo: